IL 21 SETTEMBRE 2017 A VICO EQUENSE ALDO CENNAMO RICORDA BICE E GERARDO. DAL LAVORO DI GIANNI CERCHIA I MOMENTI TRAGICI DELL’OMICIDIO DI GIOVANNI FALCONE E LA REAZIONE DI GERARDO. In arrivo l’appassionata orazione di Andrea Geremicca e il video di una recente discussione su di lui.
1 L’ULTIMO DISCORSO
***
2 L’INTERVENTO DI ALDO CENNAMO
Donna, ebrea e comunista
Diario minimo di Bice Foa Chiaromonte
Sono grato a Franca e Silvia dell’invito a questo incontro ennesimo segno di affetto e amicizia che, come loro sanno, sono da sempre sinceramente contraccambiati. Mi verrebbe da dire, quasi sfidando idealmente l’ironia di Bice, che se l’invito è partito dalle figlie non sarebbe dispiaciuto neanche alla madre. Del resto ebbi già l’onore di presentare la prima edizione di “Donna, ebrea e comunista”, l’11 aprile 2007 qui, a Vico Equense, presente Bice che, se ne ricorderà Silvia, mi manifestò il suo apprezzamento con quel garbo e quella misura che erano la sua cifra.
Non si può che condividere la scelta delle figlie di svolgere questa riflessione, questo momento di ricordo di Bice, nel giorno in cui avrebbe compiuto il suo ottantasettesimo compleanno e di tenere opportunamente questo incontro qui, a Vico Equense. Infatti era qui che Bice, insieme a Franca, Silvia, Gerardo, agli amici storici ed a quelli che abitualmente o occasionalmente passavano di qui per scambiare qualche opinione o semplicemente per un momento conviviale, trascorreva momenti di serenità e di riposo, lontano dalle abituali fatiche quotidiane. Periodi che erano sempre da considerarsi, Stabiae docet, Otium ludens, come da tradizione millenaria di questi luoghi.

Come pure m’è sembrata opportuna la scelta di ripubblicare, a poco più di dieci anni dalla sua prima edizione, il “diario minimo” di Bice che ci consente di conoscere, attraverso il racconto della sua vita, la poliedrica personalità di una donna straordinaria che ha saputo vivere il suo tempo da protagonista.
Massimo Ghinolfi, nella introduzione a “Donna, ebrea e comunista”, ci ricordava come Bice al termine del loro incontro avesse, con simpatica ironia, dato appuntamento a tutti “ai prossimi venti anni, con la promessa — scrive Massimo Ghinolfi — di raccontarci quella parte della sua storia che ancora non aveva avuto la forza di svelare”. Ed ora che Lei non è tra noi non posso trattenermi dall’immaginare, con l’animo pieno di affetto e malinconia, con quanta divertita ironia Bice avrebbe giustificato il suo mancato appuntamento che ci ha impedito d’appagare la curiosità che lei stessa aveva suscitato in tutti noi con la sua promessa.
“Donna, ebrea e comunista” è un bel libro da leggere. Confesso di aver provato piacere anche nel rileggerlo, pur con un senso di angoscia per le tante sofferenze patite da Bice che ci vengono ricordate. Molte sono le riflessioni e i ricordi, cui la lettura ci rimanda, soprattutto guardando alle ansie, alle inquietudini, che oggi attraversano il nostro presente. Il libro è in primo luogo la storia di una persona che attraverso i suoi ricordi, di donna italiana, comunista e di famiglia ebraica, ricostruisce la vicenda della sua vita, della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi compagni. Una vicenda che si sviluppa lungo l’arco temporale che va dagli anni ’30 del Novecento fino all’alba del nuovo millennio e che vive, dunque, dentro la storia del nostro Paese, dell’Italia. L’intreccio delle vicende personali si coniuga con gli avvenimenti tragici ed esaltanti di quel periodo: il fascismo, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei, la II Guerra mondiale, i campi di sterminio, ma anche la Resistenza, la Repubblica, la costruzione dell’Italia democratica. Gli intrecci, poi, di relazioni, di amicizie e l’incontro con tante personalità della cultura, della politica, fa sì che il racconto di Bice diventi anche ‘storia collettiva’ di quanti, insieme alla protagonista, hanno vissuto e partecipato a quelle vicende. Insomma, un viaggio nell’Italia e nelle diverse Italie che si incontrano attraverso la storia di Bice.
L’impatto con i ricordi, che Bice ci propone, ci fa riflettere sull’importanza della memoria. L’esercizio della memoria aiuta a coltivare le radici di una persona, di una famiglia, di un popolo: senza memoria non avremmo le chiavi interpretative per capire il nostro presente e, forse, a maggior ragione oggi, sarebbe più difficile, senza l’alfabeto della memoria, immaginare il nostro futuro. “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare”, ha scritto Primo Levi ne ‘I sommersi e i salvati’.
La lettura del libro suggerisce molte riflessioni, ve ne propongo alcune. Ho detto un bel libro, non a caso.
La parte che più mi ha colpito è quella relativa alla infanzia di Bice. L’ho trovata molto delicata ed ho visto espressa in quelle pagine una straordinaria sensibilità. I ricordi della bambina di allora non risultano alterati dal tempo. O meglio la maturità non ha alterato, nella trasposizione letteraria, il ricordo della bambina di allora. Emozionano l’estrema semplicità e la delicatezza con cui sono descritti avvenimenti tra i più tragici della storia dell’umanità, ovvero la tragedia vissuta dagli ebrei per la loro “imposta diversità”. L’orrore dell’annullamento della dignità della persona e, insieme, la programmata eliminazione di milioni di donne, uomini, bambini, anziani…, la distruzione di una cultura millenaria, in nome della ‘purezza della razza’, del ‘sangue’.
Nel Capitolo ‘Ricchi commercianti ebrei’, a pag. 63, Bice scrive: “sentivo l’atmosfera pesantissima e provavo un forte senso di paura, non capivo quasi niente di quello che succedeva”. C’è qui il racconto di quell’orrore vissuto con gli occhi di una bambina che ascoltava le ansie degli adulti e non capiva. Non poteva capire! Forse non capivano, non potevano capire, nemmeno gli adulti di allora, nonostante, come racconta Bice, i seppur lievi ‘segnali’. Ma perché non potevano capire? Perché quegli avvenimenti furono vissuti ‘uno alla volta’ e limitatamente, non vi era insomma la consapevolezza di quanto realmente stesse accadendo globalmente e quanto fosse profondo il baratro in cui si stava precipitando. Questo fu particolarmente vero per l’Italia dove, a differenza della Germania, tutto avvenne molto rapidamente. Infatti, le leggi razziali furono promulgate nel novembre del 1938, pochi mesi dopo la pubblicazione del ‘Manifesto della Razza’, nel luglio ’38, redatto dal Ministero della cultura popolare in cui si affermava il concetto biologico della razza, l’esistenza della razza italiana e l’estraneità ad essa degli ebrei.
Nello stesso ’38 e poi nel ’39, in soli sette mesi, vi fu la traduzione legislativa del Manifesto:
– nel novembre ’38, fu vietato il matrimonio tra italiani di razza ariana e di altre razze;
– tra il novembre ’38 e il febbraio ’39 fu varata la legge che imponeva limiti alla proprietà immobiliare e alle attività commerciali e industriali (misura che colpiva la famiglia Ascarelli);
– nel giugno ’39 fu limitato l’esercizio delle libere professioni, istituiti albi separati per i professionisti ebrei che potevano esercitare la professione solo a favore di persone della stessa razza; – infine, fu inibito il servizio militare agli ebrei e il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, l’assunzione di domestici ariani e posti limiti in materia testamentaria. Furono stabiliti limiti di attenuazione solo a favore di coloro che vantavano particolari benemerenze patriottiche nelle guerre combattute dall’Italia, sulla falsariga di quanto i nazisti avevano previsto fino ad allora per gli ebrei tedeschi. La discrezionalità della valutazione era affidata al Ministero dell’interno, su parere di una apposita commissione, ovvero, il tribunale della razza.
È fin troppo facile intuire come queste misure sconvolsero totalmente la vita delle persone, delle famiglie e delle loro relazioni umane, sociali, culturali, professionali.
È stato detto che l’efficacia della persecuzione antisemita in Italia fu in parte attenuata dalla scarsa partecipazione popolare alla svolta razzista del regime. La stessa Bice ci racconta della solidarietà che ci fu in quel periodo verso la sua famiglia e degli stessi comportamenti non oppressivi di alcuni funzionari di polizia più discreti nell’eseguire i controlli, ‘la perquisizione’. Ciò nonostante occorre ricordare che dopo l’8 settembre quasi ottomila ebrei italiani furono deportati e pochi di questi sopravvissero. Il dolore delle deportazioni divenne una lunga pena, prolungata dall’attesa di avere notizie sulla sorte dei deportati. Una pena che si protrasse per molti e molti anni, fin dopo la liberazione dell’Europa dal nazi-fascismo.
Cosa diversa fu in Germania, dove già il programma politico del nazionalsocialismo tedesco del 1920 esigeva l’espulsione degli ebrei dalla vita politica, culturale, economica della Germania. Obiettivo di quel programma era quello di determinare la condizione sociale dei tedeschi in base alla purezza della razza e, dunque, l’instaurazione dell’egemonia tedesca attraverso il ‘popolo dominatore’ (Herrenvolk) e la costruzione del grande Reich sotto la guida della ‘razza dominatrice’ (Herrenrasse’).
Il nemico per eccellenza era identificato nella razza ebraica, “fonte di decadenza politica e culturale della Germania”. Insomma, gli ebrei furono indicati come i veri colpevoli delle sciagure della Germania e, in particolare, della sconfitta nella prima guerra mondiale. L’antisemitismo ebbe piena e sistematica applicazione legislativa dal 1935 con le Leggi di Norimberga. Tra queste:
– la prima legge sulla cittadinanza del Reich che stabiliva che i cittadini a pieno titolo fossero soltanto i soggetti di sangue tedesco, mentre gli ebrei venivano privati dei diritti civili e politici;
– la seconda legge ‘per la difesa del sangue e dell’onore tedesco’ vietava i matrimoni tra i cittadini di sangue tedesco ed ebrei, fissava la nullità di quelli già contratti. Ma prima ancora delle leggi di Norimberga vi era già stata una intensa attività legislativa accompagnata da una feroce persecuzione poliziesca. E qui l’elenco degli orrori è lungo… Oltre ai comitati di azione per il boicottaggio dei negozi, delle professioni esercitate dagli ebrei (marzo ’33), nel luglio del ’33 fu varata una legge che prevedeva la sterilizzazione chirurgica per gli affetti da gravi patologie ereditarie e, nell’ottobre del ’39, fu varata la legge che prevedeva ‘la morte per grazia’ per le “creature umane difettose”, per le “vite indegne d’essere vissute”, fu l’«Ausmerzen»[1].
Furono 275mila le persone eliminate tra disabili e malati di mente… Fu il macabro preludio alla “soluzione finale” decisa da Hitler tra il ’41 e il ’42[2], in piena guerra, che portò allo sterminio di 6 milioni di ebrei oltre alle centinaia di migliaia di rom, che vivevano in Europa, e di omosessuali. Questi ultimi furono perseguitati in base all’art. 175 del codice penale tedesco che, oltre a punire “gli atti venerei contro natura”, puniva anche “le fantasie omosessuali”.
Si potrebbe osservare, ed io ne sono consapevole, che ho indugiato troppo su questo aspetto… ma togliere la polvere dalle vicende di quel periodo, per ricordare e fare capire ai giovani ed a quanti non hanno alcuna cognizione di quelle atrocità, è anch’esso esercizio della memoria.
Ed è Hobsbawm, ne “il secolo breve”, che ci ricorda quanto importante sia alimentare la cultura della memoria: “la distruzione del passato, o meglio, la distruzione dei meccanismi sociali che connettono l’esperienza dei contemporanei a quella delle generazioni precedenti, è uno dei fenomeni più tipici e insieme più strani del Novecento. La maggior parte dei giovani alla fine del secolo è cresciuta in una sorte di presente permanente nel quale manca ogni rapporto organico con il passato storico del tempo in cui essi vivono. Questo fenomeno fa si che la presenza e l’attività degli storici, il cui compito è di ricordare ciò che gli altri dimenticano, siano ancora più essenziali alla fine del secondo millennio di quanto mai lo siano state nei secoli scorsi”.
In questo senso il “diario minimo” è anche un contributo alla conoscenza storica poiché, come scrive Benedetto Croce (“La storia come pensiero e come azione”): per remoti…. che sembrino cronologicamente i fatti presi a considerare, è sempre storia contemporanea, è storia riferita al bisogno e alla situazione presente che la suscita e la crea… ecco perché ogni storia è contemporanea, in quanto la ricerca sul passato è sempre frutto di interessi, domande, curiosità che nascono dall’oggi…”. E dall’oggi avanzano profonde inquietudini e paure, con troppe somiglianze col passato, che spingono verso nuove forme di intolleranza, di razzismo e di xenofobia. Il debole ancoraggio a valori forti favorisce, nel nostro presente, il diffondersi di sentimenti di chiusura, di distanza, se non di odio, da ogni diversità.
Tornando al diario e alla descrizione delle sofferenze patite, va sottolineato come la protagonista con senso del pudore e composta dignità non indulge mai a presentarsi come vittima.
Mi ha colpito, pag. 290, quando dice “non dimentico e non perdono i responsabili…”. Dunque Bice non dimentica e non perdona!
Mi ha colpito perché, ed è la sensazione che ho avuto come lettore, poiché non ho trovato né in queste parole, né in tutta la narrazione, nessuna traccia di odio. E quel ‘non dimentico’ ci richiama ancora una volta, come obbligo morale, all’esercizio della memoria. Al pari di quanto scritto da Primo Levi, in polemica con Jean Amèry, sul concetto di ‘rendere il colpo’ (ne: Intellettuale ad Auschwitz), “Chiedo giustizia, ma non sono capace personalmente di fare a pugni né di rendere il colpo. Non ho la tendenza a perdonare, non ho mai perdonato nessuno dei nostri nemici di allora, né mi sento di perdonare i loro imitatori in Algeria, in Vietnam, nell’Unione Sovietica, in Cile…
La storia che Bice racconta si intreccia con quella che fu l’originale esperienza del P.C.I. nella Napoli del dopoguerra, dove Bice conosce e frequenta i tanti protagonisti che animarono quella straordinaria stagione politica. Sarebbe molto lungo scorrere l’elenco delle tante personalità ricordate da Bice e che tanti di noi, in relazione all’età anagrafica ed ai ruoli di responsabilità rivestiti nel P.C.I. in quegli anni e in quelli successivi, hanno avuto modo di conoscere.
Di Salvatore Cacciapuoti, uno dei protagonisti del ‘caso Piegari’ di cui molto s’è discusso in questi ultimi anni, D’Alema dice “nella Napoli della guerra e del dopoguerra” il P.C.I. ha “saputo tenere insieme il mondo popolare, proletario e il mondo intellettuale… una figura come Cacciapuoti senza gli intellettuali sarebbe diventato semplicemente stalinista, ma questi intellettuali senza Cacciapuoti sarebbero stati semplicemente liberali”.
Ero un bambino quando ho conosciuto Cacciapuoti e la sua presenza mi ha accompagnato anche negli anni in cui ho ricoperto ruoli di responsabilità nel P.C.I. La sua storia si intreccia con quella della mia famiglia per il particolare rapporto di amicizia che Caccia aveva con mio padre e con il mio quartiere, Ponticelli, dove aveva conosciuto la moglie Euterpe. Come facilmente si evince la lettura del diario ha provocato anche in me una sensazione di identificazione, nel senso di riconoscersi in parte del racconto perché scopri che alcuni degli avvenimenti descritti è come se li avessi già vissuti nel racconto dei tuoi genitori, dei tuoi familiari che hanno vissuto quel periodo storico… il sabato fascista… le piccole italiane… “sentirsi uguale alle altre” come… nel racconto della mia seconda madre che, ragazza, “voleva sentirsi uguale alle altre”, voleva sentirsi una ‘piccola italiana’, ciò che mio nonno socialista, invece, non gli consentì mai d’essere.
Poi ci sono episodi riferiti ad anni più recenti che potrebbero stare dentro questo racconto. Per questa ragione la “identificazione” diventa più forte poiché le vicende descritte e i ricordi suscitati sono sì di Bice, ma sono al tempo stesso frammenti di un’unica storia. Quella del P.C.I. che è anche la storia di tanti di noi, di tanti militanti che l’hanno vissuta ed animata.
Bice resterà nel nostro pensiero. La ricorderemo come una persona che ha lasciato una traccia visibile di sé perché, come scriveva Gramsci, ricordando Voltaire, “si è responsabile di ciò che si fa, ma anche di ciò che non si fa”, denunciava così il vecchio vizio, molto attuale, “quello di stare alla finestra, chiamarsi sempre fuori, non assumersi responsabilità pubbliche…”. Bice come donna e come intellettuale non è stata alla finestra. Per il nostro presente e per il futuro è questo l’esempio di donna (unica, per fortuna di tutti, irripetibile, come lei stessa ironicamente diceva di sé) a cui ci piace guardare, che con la sua dignità, libertà di pensiero e senza rimpianti o nostalgia ci lascia un messaggio di fiducia e di speranza.
Vico Equense, 21 settembre 2017
Aldo Cennamo

[1] Ausmerzen è una parola di origine tedesca, che significa estirpare, o sradicare, ed è stata conosciuta dal grande pubblico italiano grazie a uno spettacolo di Marco Paolini trasmesso su La7 il 26 gennaio 2011, alla vigilia della Giornata della Memoria. Il racconto, in particolare, era intitolato «Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute», ed è stato messo in onda in diretta senza interruzioni pubblicitarie. La narrazione di Paolini era dedicata alle teorie dell’eugenetica, che i nazisti nel secolo scorso misero in pratica nei confronti dei malati di mente e dei disabili. «Ausmerzen — scrive Paolini nell’introduzione del libro in cui ha riprodotto il suo spettacolo — ha un suono dolce e un’origine popolare. È una parola di pastori, sa di terra, ne senti l’odore. Ha un suono dolce, ma significa qualcosa di duro, che va fatto a marzo. Prima della transumanza, gli agnelli, le pecore che non reggono la marcia, vanno soppressi».
[2] Nella c.d. “Conferenza di Wannsee” che si tenne il 20 gennaio 1942, in una villa sulla riva del lago Wannsee a Berlino, fu pianificato lo sterminio degli ebrei. L’ordine per l’avvio della conferenza fu dato dal Reichsmarschall Hermann Göring su proposta di Hitler.
***
3 NEL LAVORO DI GIANNI CERCHIA
Da GERARDO CHIAROMONTE. UNA BIOGRAFIA POLITICA. Dai Quartieri Spagnoli alla Commissione Antimafia. Carocci 2013
“… Gran parte delle soluzioni normative suggerite dall’antimafia e adottate dal Parlamento erano ispirate direttamente all’esperienza sul campo condotta dalla magistratura palermitana, con la quale il presidente della commissione prendeva contatto nel corso della prima «visita ufficiale», nel 1988. «Fu in occasione di questo viaggio», scriveva Gerardo poco prima di morire, che conobbi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino»[1]. Il rapporto con il primo si approfondiva ulteriormente durante la permanenza al DAP, quando il giudice, terminato il lavoro al ministero (Largo Arenula si trova a poca distanza dalla residenza dei Chiaromonte, a Trastevere), andava a trovarlo intorno alle 22 «nei giorni di dialisi, sapendo che a quell’ora il periodo del “riposino” era trascorso»[2]. Nasceva un’amicizia che s’interrompeva soltanto con la tragica scomparsa di Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta (Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani), uccisi nell’attentato mafioso di Capaci, il 23 maggio del 1992. Per Chiaromonte era un colpo devastante; appresa la notizia mentre era sottoposto alla dialisi, faceva «l’inferno per farsela staccare» e poter così accorrere sul luogo della tragedia[3], pagando il prezzo di un gravissimo peggioramento delle sue condizioni di salute […]
Quando esplodeva la tangentopoli napoletana — che coinvolgeva non soltanto importanti esponenti della DC e del PSI, ma anche personalità del PDS come Berardo Impegno (recentemente assolto da tutte le accuse) — Chiaromonte si fiondava immediatamente in città per partecipare alla sofferta assemblea del partito, convocata per il 5 aprile del 1993 al Cinema Adriano. Il suo intervento era un vero e proprio testamento politico. Non tanto per il fatto che sarebbe morto di lì a qualche ora, ma per i toni davvero inusuali che adoperava. Per la prima e unica volta in tutta la sua esistenza era incapace di tenere distinti ragione e sentimento, pubblico e privato; intrecciava invece tutte queste dimensioni, con una passione a tratti drammatica e commovente. «Sono qui», esordiva, «per solidarietà al partito, al gruppo dirigente, a tutti voi in un momento così difficile»:
«Ho fiducia nei magistrati, e mi auguro sinceramente che i compagni inquisiti risultino estranei e possano dimostrare la loro innocenza […] Quello che dico non c’entra con la vicenda di questi giorni. Ma sento la necessità di dirlo […] Dobbiamo recuperare un rigore nella vita personale e pubblica di ciascuno di noi, del Partito. Questo era lo stile e l’insegnamento che abbiamo ricevuto nel passato da grandi uomini: Amendola, Cosenza, Cacciapuoti, Alicata, Palermo e tanti altri […] Io ho finito. Vi auguro di riprendere e di portare avanti la grande tradizione, che fu del PCI, di moralità, di trasparenza, di assoluta dedizione alla causa dei lavoratori […] Tutto ciò ve lo dico non per paternalismo. Sono vecchio, sono in questo partito dal 1943… Queste cose posso dirle per l’esperienza che ho… Ma soprattutto ve le dico per la passione che mi lega a voi, a questo nostro Partito… E ve lo dico con franchezza, con amore»[4].
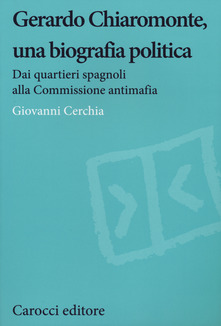
Era molto provato. Il giorno dopo l’aspettava la solita dialisi che doveva iniziare alle 13 e 30 in una clinica di Torre del Greco. Per strada, però, uno sciopero di lavoratori bloccava per ore la circolazione stradale, facendolo arrivare con moltissimo ritardo all’appuntamento con i medici. Era il trauma finale: lasciato l’ospedale in tarda serata alla volta della casa di Vico Equense — nonostante l’insistenza di Bice a non mettersi nuovamente per strada, ma di riposarsi e rientrare il giorno successivo — vi giungeva verso l’una di notte. «Un colpo di tosse all’alba è stato l’ultimo suo segno di vita»[5].
C’è stato chi ha voluto leggere in questa conclusione il terribile compiersi di un contrappasso: una morte provocata da quei lavoratori che Gerardo aveva passato la vita a difendere[6]. Ma è una tesi che appare francamente forzata e molto riduttiva. Malato da tempo, moriva perché non si era risparmiato fino all’ultimo respiro, perché aveva scelto una strada che non prevedeva soste e deviazioni. Se proprio vogliamo cercare delle responsabilità, aveva iniziato a spegnersi fin da quando il botto di Capaci lo aveva fatto fuggire via dalla clinica, senza terminare la terapia e facendo partire il conto alla rovescia della sua fine. In senso lato, Chiaromonte potrebbe essere considerato la sesta e ultima vittima della strage mafiosa.
«Per vivere», ricordava Andrea Geremicca nella cerimonia funebre che si teneva il 9 aprile a Vico Equense, «Gerardo aveva bisogno di agire, di combattere, di sentirsi utile al Partito e al Paese»:
«e così ha fatto. È venuto all’Adriano. Ha attraversato solo, a passi stanchi, lontani, la grande sala nel silenzio di tutti noi. Ed ha parlato, sofferente […] ma fermo, determinato, cocciuto […] ed era la prima volta che gli abbiamo sentito rompere il muro di pudore»[7].
Poi si spegneva, esattamente com’era vissuto: da militante del suo partito, da combattente per il riscatto del Mezzogiorno e da servitore della Repubblica democratica. Non credo, se avesse potuto farlo, che avrebbe scelto di andarsene in un modo diverso[8]. “
Gianni Cerchia

[1] Gerardo Chiaromonte, I miei anni all’antimafia (1988-1992), cit., p. 22.
[2] Bice Foà Chiaromonte, Donna, ebrea e comunista, cit. p. 282.
[3] Ivi, p. 283.
[4] Id, L’ultimo discorso, ora anche in Id., I miei anni all’antimafia (1988-1992), cit., pp. 145-146.
[5] M.C., È morto Gerardo Chiaromonte, in «la Repubblica» dell’ 8 aprile 1993.
[6] Cfr. Maria Pia Rossignaud, Amaro destino: la dialisi ritardata per la protesta dei «suoi operai», in il «Roma» dell’8 aprile 1993; Pietro Perone, Ucciso dallo stress d’un giorno da cani, in «il Mattino» dell’8 aprile 1993.
[7] Andrea Geremicca, In ricordo di Gerardo Chiaromonte, in AGC, b. Foto e materiali. Per i messaggi di condoglianze, cfr. in ivi, bb. 7 aprile 1993 (a), 7 aprile 1993 (b).
[8] Gli articoli che il giorno dopo, l’8 aprile, la stampa dedicava al suo ricordo erano innumerevoli. A titolo di esempio, senza volerne fare un elenco esaustivo, cfr. Walter Veltroni, Un militante della democrazia, in «l’Unità»; Bruno Gravagnuolo, Ingrao: «Quanti dissensi, ma quanta lealtà…», in ibidem; Umberto Ranieri, Voleva il Pds perno di una nuova unità, in ibidem; Pasquale Nonno, Il bene del Paese al di sopra di tutto, in «il Mattino»; Emanuele Macaluso, Una vita segnata dall’esperienza meridionalista, in «Il Giorno»; Francesco De Martino, Alta figura di compagno che riabilita la politica, in «la Repubblica»: Valentino Parlato, 50 anni di storia, «col senno di poi», in «il manifesto; Paolo Franchi, Un togliattiano meridionalista curioso delle ragioni degli altri, in il «Corriere della Sera»; Antonio Landolfi, Voleva un partito di governo, fuori dalle fumosità ideologiche, in «l’Avanti!»; Paolo Cabras, La scomparsa di Chiaromonte. Illustre meridionalista e comunista «liberale», in «Il Popolo»; Nino Calice, Il rigore di Gerardo Chiaromonte, in «Il Centro»; Guido Compagna, Chiaromonte un testimone del nuovo Sud, in «Il Sole 24 ore».


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.